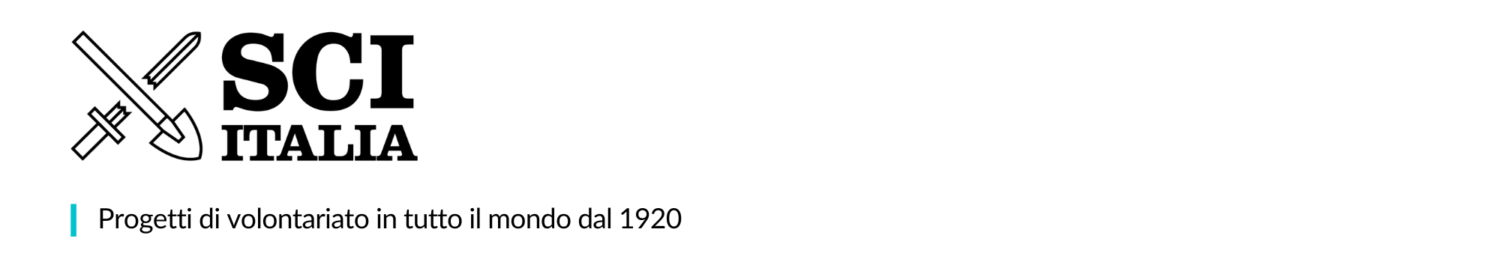Dal 16 al 26 dicembre si è tenuto, nel campo profughi di Diyarbakir, nel Kurdistan turco, un campo di volontariato organizzato da SCI-Italia in collaborazione con “Genclik ve degisim, Youth and Change Association”. All’interno dell’area, gestita dalle municipalità curde, vivono circa 4mila rifugiati, 1.500 dei quali sono bambini, per la maggior parte Yazidi, fuggiti dal monte Sinjar a seguito dell’attacco dell’ISIL. Alberto, uno dei volontari, racconta la sua esperienza.
Dal 16 al 26 dicembre si è tenuto, nel campo profughi di Diyarbakir, nel Kurdistan turco, un campo di volontariato organizzato da SCI-Italia in collaborazione con “Genclik ve degisim, Youth and Change Association”. All’interno dell’area, gestita dalle municipalità curde, vivono circa 4mila rifugiati, 1.500 dei quali sono bambini, per la maggior parte Yazidi, fuggiti dal monte Sinjar a seguito dell’attacco dell’ISIL. Alberto, uno dei volontari, racconta la sua esperienza.
È sera, dopo 5 ore di volo atterro a Diyarbakir.
Perché sono venuto qui nel Kurdistan turco? Sapevo per lavorare nel campo con altri volontari, insieme ai rifugiati Yazidi fuggiti dal monte Sinjar, nel Kurdistan iracheno, dopo l’attacco dell’ISIL. Sapevo anche che all’interno del campo profughi vivono circa 4.000 rifugiati, 1.500 dei quali sono bambini. Quello che non sapevo era l’umanità che avrei respirato.
Si inizia!
Le attività previste sono state organizzate la prima giornata di campo. Ma giorno per giorno, la sera, venivano condivisi e decisi i dettagli sul da farsi nella giornata successiva.

Il primo dì al campo è stato di conoscenza con il posto, le persone, gli ospiti e gli altri volontari locali. Abbiamo poi avviato le prime timide amicizie con i bambini più piccoli e poi con tutti gli altri più grandicelli.
In base anche alle esigenze espresse dagli insegnanti e dai ragazzini abbiamo capito che le lezioni di inglese sarebbero state preziose. Così tutte le mattine, durante il campo, abbiamo tenuto due classi di inglese, divisi in due coppie di volontari per aula, una composta dai più piccoli (sotto gli 8 anni) e l’altra fino ai 12/13 anni.
All’ora di pranzo, i bambini tornavano alle tende e noi si mangiava nel prato ad un centinaio di metri dai contaner della scuola. Il pranzo era il momento della condivisione, tra noi volontari, di come stavamo vivendo quelle mattinate.
Dopo la pausa riprendevamo le attività, in particolare all’aperto, con giochi organizzati per i bambini. Giochi semplici, come “un, due, tre stella”, nascondino o la corsa coi sacchi.
Altre volte abbiamo avuto la possibilità di incontrarci con i responsabili della comunità, di parlare con loro in inglese, grazie alla traduzione di Umut, il coordinatore del campo, e degli altri volontari locali. Abbiamo chiesto di tutto: perché erano li, come stavano, di cosa avevano paura, da chi/cosa scappavano e quali erano i sogni e le speranze che stavano ancora inseguendo. Certo, sapevamo chi erano, da dove arrivavano. Ma quando lo racconta un uomo, davanti a te, è difficile non commuoversi.
Altri pomeriggi abbiamo organizzato la pulizia del campo. Un po’ per gioco e un po’ sul serio, ci siamo sparsi per il campo a raccogliere cartacce e pezzi di plastica. Il campo, in tutta onestà, non mi è mai apparso particolarmente sporco, a parte alcuni punti più nascosti. Lo considero comunque molto più pulito di qualsiasi nostra periferia di Napoli, Milano o Roma.
 Un po’ a conferma di questo, infatti, ho poi saputo che la municipalità curda, che gestisce nel campo profughi la raccolta dell’immondizia, se l’era presa. Che se c’era bisogno di pulire, hanno detto, avrebbero mandato loro degli operai per farlo! Mi ha fatto piacere, perchè non c’era boriosità da buracrate in quella nota, ma molto senso della comunità e un pizzico di sano orgoglio. Il campo non era particolarmente sporco, per cui non hanno aspettato i volontari stranieri per gonfiare il petto.
Un po’ a conferma di questo, infatti, ho poi saputo che la municipalità curda, che gestisce nel campo profughi la raccolta dell’immondizia, se l’era presa. Che se c’era bisogno di pulire, hanno detto, avrebbero mandato loro degli operai per farlo! Mi ha fatto piacere, perchè non c’era boriosità da buracrate in quella nota, ma molto senso della comunità e un pizzico di sano orgoglio. Il campo non era particolarmente sporco, per cui non hanno aspettato i volontari stranieri per gonfiare il petto.
In altre due giornate abbiamo pulito, imbiancato e poi colorato insieme ai bambini le pareti esterne di un edifico scolastico. Forse si aspettavano, visto che era un italiano a gestire il tutto (io!), che uscisse fuori una cappella sistina curda!
Beh, i bambini hanno preso il controllo e ovviamente il muro della scuola è diventato un mega foglio bianco da pasticciare. Bellissimo!
Nelle attività abbiamo cercato di coinvolgere tutti, ma sicuramente i bambini e gli adolescenti erano quelli più reattivi. Molte famiglie dei bambini poi ci hanno voluto ospitare nelle loro tende per offrirci un tè.
La sera, all’imbrunire, tornavamo verso la città con il nostro pulmino. Ovviamente, la facilità di movimento offerta dal pulmino ci permetteva di sfruttare bene le poche ore di luce che le settimane centrali di dicembre hanno da offrire, oltre a evitare di passare da quelle zone della città che potevano essere attraversate da manifestazioni o altre situazioni più difficili da gestire.
Il pulmino veniva a prenderci al mattino, appena sotto la palazzina di 8 piani dove stavamo, e ci accompagnava fin dentro il campo, che distava circa 20 km dalla città.
La palazzina è in una zona abbastanza vicina a Sur (200/300 metri), quartiere soggetto a coprifuoco da parte dell’esercito turco. Ma in nessuna circostanza abbiamo avuto problemi o ci siamo trovati in mezzo a scontri, nemmeno visti da lontano.
 Solo la notte e la sera arrivavano nitidi i colpi dei fucili AK-47 e di qualche mortaio. La prima notte che li senti non sei contento, la seconda ancora ci fai un po’ caso, poi c’erano ma non ci facevi più caso. Salvo, talvolta, fermarti dopo un colpo e pensare che forse un uomo era appena morto.
Solo la notte e la sera arrivavano nitidi i colpi dei fucili AK-47 e di qualche mortaio. La prima notte che li senti non sei contento, la seconda ancora ci fai un po’ caso, poi c’erano ma non ci facevi più caso. Salvo, talvolta, fermarti dopo un colpo e pensare che forse un uomo era appena morto.
L’organizzazione del tempo nel campo profughi era decisa in comunità: per cucinare e lavare i piatti ci si divideva, spesso se ne occupavano i volontari locali. Uno di loro era sempre presente nel campo profughi, Hussein, ma anche altri ci davano una mano nelle varie attività. Umut e Hussein, come gli altri volontari locali, quando presenti, dormivano e mangiavano con noi, nella guest house dell’associazione locale.
Durante il campo abbiamo avuto la possibilità di conoscere il padre di Umut, che ci ha ospitati tutti a casa sua per un tè. Ci ha raccontatto degli anni trascorsi nelle carceri turche, a causa della sua lotta contro la loro oppressione. È venuto a casa anche un altro signore, che da anni aiuta profughi e militanti curdi a farsi accettare nei centri medici ospedalieri turchi per avere assistenza sanitaria.
Rimane la voglia, oggi, di capire meglio e ritornare.